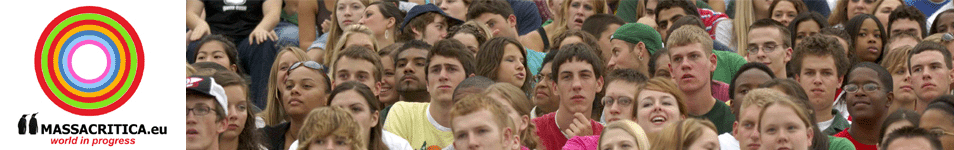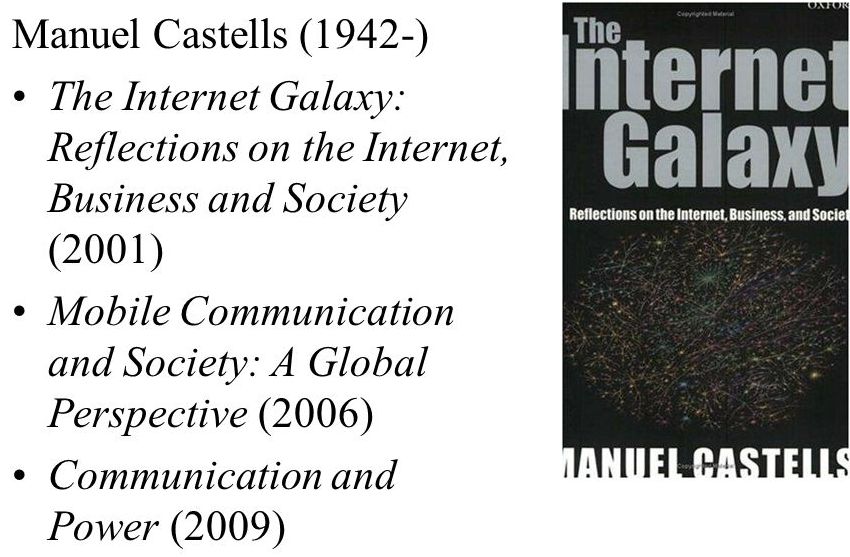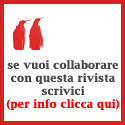Nel marzo 2005, le Nazioni Unite inaugurano un programma molto atteso, un “Fondo di solidarietà Digitale”, inteso a sottoscrivere iniziative che affrontino” la distribuzione e l’uso non uniforme di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione “e” che consentano alle persone e ai paesi esclusi di entrare nella nuova era della società dell’informazione. “Cosa potrebbe significare questo nella pratica: il digitale può fare una differenza significativa per chi è ancora fuori…
Dibattiti sul Fondo al primo incontro del mondo sulla società dell’informazione (WSIS)
Il vertice sulla società dell’informazione (WSIS) del dicembre 2003 è sintomatico per la complessità delle questioni sul “divario digitale” che sono state anche centrali nella seconda fase del Vertice tenutosi nel novembre 2005 in Tunisia.
Si considera il rapporto tra le popolazioni indigene e le nuove tecnologie dei media che le persone di queste comunità hanno iniziato ad utilizzare diffusamente, nell’ultimo decennio, ma con qualche perplessità. Perché le loro preoccupazioni sono appena udibili nelle discussioni sui nuovi media? Vorrei suggerire che parte del problema ha a che fare con l’aumento del termine, nell’ultimo decennio, “The Digital Age” e le ipotesi che lo supportano. Mentre inizialmente aveva il fascino della novità, ora, per molti di noi, è diventato naturale – operatori culturali occidentali e intellettuali – come segno temporale del dominio di una certa tecnologia, di un regime (“il digitale”) come è “l’associazione del Paleolitico” con alcuni tipi di strumenti di pietra per i paleontologi. Ciò sembra ancora più notevole date certe realtà: solo il 12% del mondo è attualmente cablato (secondo le stime del World Economic Forum di gennaio 2005 a Davos) e solo 16 persone su 100 della popolazione mondiale sono dotate di linee telefoniche via terra.
Ma per un antropologo che ha speso una buona parte della sua carriera guardando alla diffusione di media in comunità indigene remote, l’etnocentrismo non esaminato che sorregge le ipotesi sull’era digitale sono scoraggianti. Non sto suggerendo che i massicci cambiamenti della comunicazione, della socialità, della produzione della conoscenza e della politica, che Internet consente, siano irrilevanti per le comunità remote; la mia preoccupazione riguarda il modo in cui la lingua contrae un insieme di cose digitali radicalmente diverse e che quindi servono a isolare ulteriormente il pensiero dal riconoscimento di alterità che diversi tipi di mondi multimediali presentano, in particolare aree chiave come la proprietà intellettuale.
In questo articolo, viene analizzato come concetti come l’era digitale abbiano assunto un senso di inevitabilità evolutiva, creando così una crescente stratificazione ed etnocentrismo nella distribuzione di determinati tipi di pratiche dei media, nonostante le tendenze precedenti e recenti a de-occidentalizzare gli studi sui media. Guardando ai nuovi e vecchi media prodotti dagli indigeni, le comunità suggeriscono come questo nuovo lavoro possa espandersi e complicare le nostre idee sull’era digitale in modi che tengano conto di altri punti di vista nel cosiddetto villaggio globale.
Una storia di dibattiti digitali.
Permettetemi di passare al mio primo compito rivedendo brevemente alcuni dei recenti dibattiti intorno alla retorica dell’era digitale, perché certamente non sono il solo a preoccuparmi, anche se la mia potrebbe essere una riflessione particolare. Tra le fila di coloro che hanno scritto “Produzioni culturali in un’era digitale” e le sue implicazioni globali, c’è qualche critica che riguarda “Se è appropriato, dato l’accesso ineguale alle tecnologie avanzate (per non parlare delle più basilari merci)” in diverse parti del mondo, che il termine “The Digital Age” sia usato per definire il periodo attuale (Klineneberg e Benzecry, 2005). Questo dibattito avviene in parallelo con quello del “The Digital Divide”, la frase inventata per descrivere le circostanze della disuguaglianza che caratterizzano l’accesso (o la mancanza di accesso) alle risorse, tecnologiche e non, trasversali a gran parte del globo. Anche se è una preoccupazione fondata, il termine nondimeno invoca un linguaggio neo-evolutivo che presuppone una cultura meno privilegiata, enclaves, con poco o nessun accesso alle risorse digitali, dal “South Bronx” al “Sud globale” che semplicemente aspetta, senza un termine, di raggiungere il livello di sviluppo dell’ovest del mondo, che si tratti della Silicon Valley o del MIT Media Lab. Il New York Times e il Wall Street Journal forniscono affascinanti possibilità di speranza, storie di lontani villaggi che “recuperano” verso ovest, come illustrato in un articolo del New York Times, da James Brooks (2004), che descrive il lavoro di Bernard Krisher, che rappresenta sia il Media Lab del MIT che il gruppo “American Assistance for Cambodia”, a O Siengle, in Cambogia, un villaggio di meno di 800 persone ai margini della foresta, emblematico della vita per i milioni di asiatici che vivono il lato “non voluto” del digital divide. Attraverso il progetto Motoman, il villaggio collega la sua nuova scuola elementare a Internet. Dal momento che non hanno elettricità o telefoni, il sistema è alimentato da pannelli solari, Scrive Brooks: Un “Motoman” di Internet guida una motocicletta rossa lentamente oltre la scuola [una volta al giorno]. Sopra il sedile del passeggero c’è una scatola di metallo grigia con un’antenna corta e grossa. La scatola contiene un set di chip Wi-Fi wireless, che consente lo scambio di e-mail tra caselle e computers. In breve, questo spazio di alberi e un pozzo d’acqua a manovella diventa un hot spot di Internet [un processo duplicato in altri cinque villaggi]. Al crepuscolo, il motociclista [dai 5 villaggi] converge sul capoluogo di provincia, Ban Lung, dove la scuola superiore è dotata di un’antenna parabolica che consente uno scambio di e-mail di massa con il mondo esterno.
Significativamente, questa storia era nella sezione Business del Times, suggerendo che la parte affascinante della storia è la possibilità di aprire nuovi mercati, il vero motore idealistico che anima questa innovativa idea tecnologica; i computer e Internet non sono affatto eccezionali.
Questo universo tecno-immaginario – di epoche e divisioni digitali – ha l’effetto, di reinscrivere il mondo in una sorta di “cronopolitica in cui “l’altro” esiste in un tempo non contemporaneo al nostro. Questo ha l’effetto di ri-stratificare il mondo lungo linee di una tarda modernità, nonostante le utopistiche promesse delle possibilità del 21° secolo di McLuhanesque, del villaggio globale. Negli ultimi due decenni, gli studiosi hanno discusso del potere di trasformazione dei sistemi digitali e della loro capacità di alterare la vita quotidiana, la politica democratica e la personalità. Il senso di un cambio di paradigma è forse più evidente nel classico di Castells, del 1996, “The Rise of the Network Society”. La premessa del suo studio è che Internet ha più o meno creato una nuova era, fornendo le basi tecnologiche per una forma organizzativa dell’età dell’informazione: la rete. Nel suo libro del 2003, “The Internet Galaxy”, la scala di Castells sembra essersi espansa dalla società al “cosmo”. Mentre celebra la capacità di Internet di liberare, ci mette in guardia anche sulla sua capacità di emarginare ed escludere coloro che non vi hanno accesso e suggerisce che, per il futuro, dobbiamo assumerci la responsabilità di questa nuova era dell’informazione.
“Creating Digital Dividends”
Riprendendo questa riflessione un po’ da più lontano, diventa illuminante la nuova posizione di Bill Gates, fondatore di Microsoft, e una volta la personificazione della nuova evangelizzazione dei media, diventato oggi esplicitamente molto più critico. In un suo discorso, in una conferenza intitolata “Creating Digital Dividends”, Gates dimostra il suo notevole cambiamento, offrendo una critica illuminante sull’idea del digital divide e della sua capacità di nascondere alle persone la reale condizione dei più poveri del globo: “O.K., vuoi inviare computer in Africa? Le madri che si troveranno tra le mani quei computer penseranno ‘I miei figli stanno morendo, cosa posso fare?’ Non staranno certo a navigare su eBay o cose del genere. Quello che desiderano è che i loro figli vivano. Serve un computer per capirlo?” Il suo chiaro disprezzo per l’idea che le persone più povere del mondo costituiscano un mercato significativo di prodotti high-tech ha avuto un certo impatto. Le priorità di Gates riguardano l’assistenza sanitaria, in particolare lo sviluppo e la distribuzione di vaccini che rappresentano i due terzi delle sovvenzioni offerte di 21 miliardi di dollari da Bill e Melinda Gates Foundation. Al World Economic Forum del 2005, mentre il guru della tecnologia, Nicholas Negroponte, pubblicizzava il suo modello di computer portatile da $ 100, sperando di affascinare 220 milioni di studenti della Cina come possibili acquirenti, Gates discuteva con quali modi era possibile eliminare la povertà e le malattie.
Internet, ovviamente, è stato accolto con ottimismo da coloro che condividevano le preoccupazioni dell’accesso alle più ampie libertà di espressione e ai movimenti sociali. Manuel Castells, in “The Power of Identity”, (1997), nota che alla rosa di attori sociali dissidenti, come gli Zapatisti in Messico, oggi andrebbero aggiunti anche una serie di gruppi dalla sinistra politica di base, organizzati da moveon.org, ai cristiani di destra e agli islamisti militanti, al Falun Gong, in Cina. Questi e molti altri gruppi hanno utilizzato Internet con successo per rompere le barriere di comunicazione, e dato forma a ciò che alcuni chiamano “la logica della rete” – movimenti di globalizzazione e mob intelligenti, così come la sua diffusione da parte dell’Islam. Inoltre, diversi ricercatori hanno notato come Internet, influenzi i cambiamenti nelle tecnologie della comunicazione, riducendo in molti casi quello che viene definito come il prezzo di ingresso in uno spazio culturale, creando opportunità per attori e organizzazioni che precedentemente erano incapaci di ottenere un loro pubblico, come i blogger durante le presidenziali del 2004.
Tuttavia, le reti digitali possono consentire la dispersione globale sia della creatività sia dell’attività politica.
Allo stesso tempo, nell’ultimo decennio, i media digitali si sono sviluppati a un ritmo accelerato, consolidando il superamento della proprietà attraverso l’open source e gli sforzi di condivisione di file.
Nel 1983, lo studioso di media Ben Bagdikian avvertì dei pericoli del monopolio dei media negli Stati Uniti, quando l’industria dei media era controllata da circa 50 società. Nel 2004, alla settima edizione del suo famoso libro “The Media Monopoly”, gli Stati Uniti risultano ora dominati da soli cinque poli societari.
Nella loro cover story del 12-18 maggio 2005, non c’è neppure un sostenitore della diffusione del “free enterprise” che presenti un ripensamento sul termine di “Real Digital”. La sua opinione principale è che “il dibattito sul divario digitale è fondato sul mito, che collegando i paesi poveri a Internet questo li aiuterà a diventare ricchi rapidamente… Quindi anche se fosse possibile agitare una bacchetta magica e far apparire un computer in tutte le famiglie sulla terra, non succederebbe granché: un computer non è utile se non si ha cibo o elettricità e non si può leggere.
Going Digital: Internet indigena “On the Ground”
Come osserva The Economist, radio e telefoni cellulari possono essere le forme di tecnologia digitale che faranno la differenza, una volta affrontati i bisogni di base (Norris, Bennett ed Entman, 2001). La mia preoccupazione, tuttavia, è se termini come il digital divide chiudono troppo facilmente la discussione su quale sia la posta in gioco per quelli che sono fuori dal potere. Piuttosto che immaginare di conoscere le risposte, dovremmo continuare ad ascoltare l’88% della popolazione della terra che si trova sul lato non cablato del cosiddetto digital divide.
Quindi cosa prova “l’era digitale” e come potrebbe supportare le comunità indigene in remote regioni del mondo in cui l’accesso alle linee telefoniche può ancora essere difficile? Recenti sviluppi danno un’idea di ciò che potrebbe effettivamente significare per i soggetti indigeni. Come Kyra Landzelius (2006) sostiene, sebbene le popolazioni indigene siano proporzionalmente non rappresentate nel cyberspazio, per ovvi motivi come la povertà economica, l’inesperienza tecnologica, l’isolamento linguistico, la repressione politica e /o la resistenza culturale – Internet ha ampiamente esteso le reti tradizionali dell’informazione e della comunicazione. Migliorando notevolmente la visibilità altrimenti marginale di comunità e individui. La superstrada dell’informazione rende anche molto piccole e isolate le comunità che provano ad espandere la loro sfera di influenza e a mobilitare il supporto politico alle loro lotte di affermazione culturale. Oltre a mantenere i contatti con le proprie comunità, le popolazioni indigene usano anche Internet per connettersi con altri gruppi dispersi nel mondo. Oggi, non è insolito per un Mi’kmaq di Terranova andare su Internet e comunicare con individui appartenenti ad altri gruppi remoti come Maori in Nuova Zelanda, Saami in Norvegia, Kuna a Panama o Navajo in Arizona. Esattamente noi, ora navigano quotidianamente attraverso Cyber spazio.
Landzelius sottolinea le circostanze in cui si usa Internet e, più in generale come l’uso multipiattaforma delle tecnologie digitali venga usato dalle comunità indigene per favorire lo sviluppo di reti politiche e la diffusione dei loro panorami culturali, come ad Alice Springs, nell’Australia centrale, dove Arrernte, ha creato un progetto interattivo innovativo chiamato Us Mob. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con un certo numero di agenzie per indigenizzare l’uso delle tecnologie digitali finalizzate alla narrazione, un modo per generare una maggior comprensione delle storie e delle culture locali, per un pubblico più ampio, ma soprattutto per il loro futuro culturale.
UsMobè è la prima serie televisive per bambini e sito web interattivo aborigeno australiano. Sul sito, gli utenti interagiscono con le sfide quotidiane che bambini del campo di Alice Springs – Harry, Della, Charlie e Jacquita – devono affrontare e seguono trame multi-percorso, attivando diari popolati da video, testi, forum, film e giochi interattivi, che offrono un esperienza virtuale del campo e dei deserti circostanti e dove si possono caricare le proprie storie video. Un recente progetto digitale è stato sviluppato da un avvocato e attivista documentarista, David Vadiveloo, in collaborazione con Arrernte Aboriginal youth in Living in Hidden Valley, in un accampamento alla periferia di Alice Springs.
Dieci anni di ascolto di molte famiglie dei campi cittadini e delle aree remote, cercando di creare un ponte di comunicazione dinamico, aperto dagli stessi bambini Arrernte di Alice Springs, quale invito a tutti i bambini mondo a giocare, condividere e coinvolgersi nei temi della storia, comuni a tutti i giovani, ma trasmessi alla società attraverso un paesaggio culturale e fisico unico.
Per tornare alla preoccupazione che ha motivato questo articolo, voglio sottolineare il modo in cui il termine Era digitale stratifichi le gerarchie dei media per coloro che sono fuori dal potere e stanno lottando per diventare produttori di rappresentazioni mediali delle loro vite. È un problema particolarmente importante per gli indigeni che, fino a poco tempo fa, sono stati oggetto di creazione di immagini da parte di altri popoli, pratiche e modi che hanno danneggiato la loro vita. E a differenza di altre minoranze, l’era digitale appare diversa dalla prospettiva di chi controlla la terra e le tradizioni, i coloni che ne esercitano il dominio da almeno 500 anni.
Nel tentativo di sottolineare il loro lavoro, uso il termine attivista culturale per descrivere il modo autocosciente, mio e di molte altre persone – di usare la produzione media, e altre forme espressive, come un modo per sostenere e costruire le loro comunità, ma anche come aiuto che si potrebbe chiamare “tradizionalismo strategico”. Questa posizione è cruciale per il loro lavoro, ma è cancellata dalla teoria della contemporaneità che affronta i nuovi media sottolineando la dislocazione e la globalizzazione. Gli attivisti culturali che creano questi nuovi tipi di forme culturali si sono rivolti a loro come mezzo per rivitalizzare le relazioni con le loro terre, le lingue, le tradizioni e le storie locali e articolare le preoccupazioni della comunità. Vedono anche i media come mezzo per promuovere la trasformazione sociale e politica inserendo le loro storie nella narrazione nazionale, quale parte delle lotte in corso per il riconoscimento e l’autodeterminazione degli aborigeni.
La sempre maggior diffusione di questi media a livello globale – attraverso conferenze, festival, coproduzioni, e l’uso di internet è diventata la base per una nascente, ma già produttiva rete transnazionale di creatori e attivisti dei media indigeni. Questi attivisti stanno tentando processi inversi attraverso cui gli aspetti delle loro società, ormai oggettivati e mercificati, attraverso le loro produzioni scritte e mediatiche possano recuperare le loro storie, la terra, i diritti e la conoscenza quali propri beni culturali. Questi tipi di produzioni culturali diventano significato e prassi della cultura nella tarda modernità, sempre più consapevole del proprio progetto, quale sforzo per utilizzare immagini della propria vita per creare un attivista immaginario. Si potrebbe pensare alle pratiche dei media come a una sorta di scudo contro usi sempre più spesso non etici e contro una cancellazione totale della loro presenza attarverso la circolazione crescente di immagini di un’altra cultura della vita indigena, che è quella che il vertice della società dell’informazione mondiale vorrebbe significare. Ad ogni modo, le pratiche dei media indigeni hanno contribuito a creare e contestare gli spazi sociali, visivi, narrativi e politici delle comunità locali e a creare, a livello nazionale, e oltre i suoi confini, altri tipi di immaginari culturali dominanti, che, fino a poco tempo fa, erano escluse dalle rappresentazioni dei popoli delle Prime Nazioni. La capacità di tali rappresentazioni di diffondersi ad altre comunità – dai vicini indigeni alle ONG – è un estensione di questo processo, attraverso una serie di forme di mediazione, che attraverso video e filmati arriva nel cyberspazio.
I media digitali indigeni hanno sollevato importanti questioni sulla politica e la circolazione di conoscenza su molti e diversi piani; all’interno delle stesse comunità questo significa anche “chi” ha l’accesso e la capacità di comprendere e usare le tecnologie multimediali e chi ha il diritto di sapere, raccontare e diffondere certe informazioni, storie e immagini. All’interno degli stati-nazione, i media sono legati a battaglie più grandi sulla cittadinanza culturale.
Possiamo illuminare e sostenere altre possibilità, emergenti dalle preoccupazioni locali e parlare della loro importanza nelle arene culturali e politiche contemporanee?
Razzismo, sovranità e diritti fondiari, così come le lotte sui finanziamenti, lo spazio aereo e i satelliti, le reti di trasmissione e la distribuzione a banda larga digitale sono o non sono disponibili al lavoro indigeno? L’impatto di queste fluttuazioni può essere monitorato in una varietà di luoghi – in lavoro sul campo, nei documenti politici e nei drammi della vita quotidiana nelle istituzioni culturali.
Io esploro il termine The Digital Age perché questo, plasma forme potenti per comprendere la globalizzazione, i media e la cultura, creando per il “discorso del buon senso” delle istituzioni, modi che ignorano il significato culturale della produzione di conoscenza delle comunità minoritarie, aumentandone il senso di marginalizzazione già esistente, piuttosto che la diffusa preoccupazione per l’aumento del controllo commerciale sulla produzione dei media e sulla loro distribuzione, e il panico spesso parallelo sul multiculturalismo (Appiah 1997).
Possiamo illuminare e sostenere altre possibilità emergenti da preoccupazioni locali e parlare della loro importanza in arene culturali e politiche contemporanee? Le strutture istituzionali sono costruite su strutture discorsive che modellano il modo in cui i fenomeni vengono compresi, cambiamenti naturali di supporto al ventaglio delle attività culturali. Nelle istituzioni governative, delle fondazione e delle accademie, questi quadri hanno un impatto enorme sulle decisioni politiche e di finanziamento che, nel bene e nel male, possono avere un effetto decisivo sulla pratica. Altri studiosi che riconoscono, più in generale, l’importanza delle pratiche culturali localmente situate, in relazione ai modelli dominanti, sottolinea invece l’importanza delle produzioni/produttori che stanno aiutando (tra le altre cose) a creare i propri legami con altre comunità indigene, attraverso le quali le pratiche locali vengono rafforzate e collegate. Ad esempio, Rob Wilson e Wimal Dissanayake puntano a tali processi come parte di “un’estetica della resistenza di retroguardia, confini riarticolati come fonti, generi ed enclavi di conservazione culturale e identità comunitaria, da contrapporre a tecnologie globali di modernizzazione o culture dell’immagine del postmoderno” (1996, p.14).
In effetti, simultaneamente al crescente controllo commerciale dei media, i produttori indigeni e gli attivisti culturali stanno creando lavoro innovativo, non solo nella forma e nelle forme delle loro produzioni, ma anche nelle relazioni sociali che stanno creando attraverso questa pratica, che può cambiare il modo in cui noi comprendiamo i media e il loro rapporto con la circolazione del “culturemore” del 21° secolo. Molti sforzi dimostrano come i media indigeni formatisi negli ultimi decenni, si trovino ora nella congiunzione di una serie di sviluppi storici: questi includono i circuiti aperti dalle nuove tecnologie dei media, dai satelliti ai video compressi e al cyberspazio, così come i lasciti in corso dell’attivismo indigeno in tutto il mondo, da una generazione che ultimamente è a contatto con i media e preoccupata di creare le proprie rappresentazioni come modalità di creatività culturale e azione sociale. Rappresentano anche i modi complessi e diversi in cui gli stati hanno risposto a questi sviluppi – le opportunità dei media e le pressioni dell’attivismo – e sono entrati in nuove relazioni con le nazioni indigene. Concludo con una nota di cauto ottimismo. Le prove della crescita e della creatività dei media digitali indigeni negli ultimi due decenni, a prescindere dai problemi che possono averli accompagnati, sono a dir poco eccezionali. Formazioni come queste, che lavorano su comunità radicate o basi regionali o nazionali interrotte, offrono un’importante elaborazione di ciò che potrebbe sembrare l’era digitale, intervenendo nella narrativa “lasciata indietro” che predomina. I media indigeni offrono un modello alternativo di radicamento, e sempre più globale interconnessione, creato dalle popolazioni indigene sulle loro vite e culture. Mentre tutti lottiamo per comprendere la rimappatura dello spazio sociale che si sta attuando, i media indigeni offrono altre coordinate per capire come un tale mondo interconnesso potrebbe diventare un ordine egemonico esterno. Termini come The Digital Age comprendono anche fenomeni come questi, esempi di modernità alternative, risorse di speranza, nuove dinamiche dei movimenti sociali, che fanno parte della traiettoria della vita indigena nel 21° secolo. Forse è tempo di inventare una “newlanguage”.
Faye Ginsburg – Dipartimento di Antropologia, New York University.
(adattamento e traduzione di Adriana Paolini)
Linkografia
https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-as/faculty/documents/Ginsburg-RethinkingtheDigitalAge.pdf
https://as.nyu.edu/content/nyu-as/as/faculty/faye-ginsburg.html
https://www.flowjournal.org/author/faye-ginsburg/?print=print-search