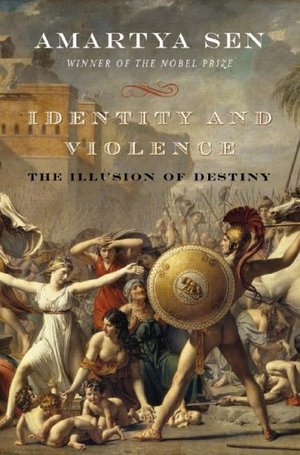Di fronte alla costante minaccia dell’Isis, che dopo gli attentati di Parigi e Bruxelles promette di insanguinare altre città europee, i media si interrogano sulla genesi del terrorismo di matrice islamica. Se, poi, gli efferati autori delle stragi del Bataclan e di Zaventem sono in gran parte cresciuti in mezzo a noi, nelle nostre stesse contrade, il sospetto è che l’Europa stia allevando una sorta di serpe in seno. Di qui, automatico, il quesito: è possibile un islam “moderato”? La religione musulmana è compatibile col “nostro” modo di vivere?
Le risposte fornite da alcuni autorevoli commentatori paiono tutte improntate alla tesi dello “scontro di civiltà”. Cioè la sostanziale incompatibilità tra cultura occidentale e Islam, al quale bisogna porre una serie di argini, pena il disgregarsi delle nostre società democratiche. Così, a più riprese, Ernesto Galli della Loggia (Corriere della Sera: 15 ottobre 2015: http://www.corriere.it/editoriali/15_ottobre_07/difficile-rapporto-l-islam-3b968bea-6cb4-11e5-8dcf-ce34181ab04a.shtml; 15 novembre 2015: http://www.corriere.it/cultura/15_novembre_16/battaglia-culturale-db4528e2-8c29-11e5-b416-f5d909246274.shtml; 16 marzo 2016: http://www.corriere.it/opinioni/16_marzo_26/noi-l-islam-rispetto-legge-867980a2-f2c1-11e5-a7eb-750094ab5a08.shtml); Alain Finkelkraut (Repubblica: 7 gennaio 2016: http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/07/news/alain_finkielkraut_liberiamo_le_periferie_dai_jihadisti_assassini_o_sara_guerra_civile_-130784757/).
Vale davvero la pena, allora, quale fertile contributo al dibattito, riprendere in mano un libro uscito giusto dieci anni fa: Identità e violenza, di Amartya Sen (Laterza 2006; ed. or. Identity and Violence. The Illusion of Destiny, Norton & Company, New York-London 2006). In duecento pagine dallo stile chiaro e asciutto, l’economista indiano premio Nobel (e “filosofo a tempo perso”, come ama definirsi) smantella la teoria dello “scontro di civiltà” di Samuel Huntington (ed. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, 2000), tanto fortunata e influente quanto rozzamente semplificatrice. Al contempo, Sen fornisce alcune idee illuminanti per orientare la discussione sulle sfide del multiculturalismo e della convivenza pacifica tra culture e fedi diverse.
Contro la teoria dello “scontro di civiltà”
Alla teoria dello “scontro di civiltà”, dice Sen, è sotteso il presupposto che le civiltà siano classificabili secondo “un sistema di ripartizione unico e sovrastante”. Seguendo il ragionamento di Huntington, esisterebbero quindi una “civiltà occidentale”, una “civiltà islamica”, una civiltà “induista”, e così via, i cui confini “guarda caso ricalcano quasi esattamente le divisioni religiose”. Ma tale approccio, che Sen definisce “solitarista”, ignora o finge di ignorare il fatto che ogni identità, sia individuale che collettiva, non è mai univoca bensì sempre complessa e plurale.
Pensiamo per un attimo ai singoli individui. Ciascuno di noi può definire se stesso in base a una pluralità di “affiliazioni”: la nazionalità, il ceto sociale, l’età, la lingua, la professione, le preferenze sessuali, le pratiche alimentari, il credo religioso, la fede politica o quella sportiva, l’essere sposato o single, ecc. Chi volesse definirci solo ed esclusivamente in base a una di queste affiliazioni compirebbe un’arbitraria “miniaturizzazione” della nostra identità. Non solo. Sen, da pensatore liberale, crede che gli esseri umani siano soggetti razionali, capaci di scegliere autonomamente cosa sia meglio per se stessi. Pertanto le affiliazioni non sono gabbie chiuse e immutabili, ma il frutto di una scelta individuale. Così, non tutti i cattolici seguono le prescrizioni della Chiesa in tema di sessualità, né tutti i musulmani osservano allo stesso modo i precetti coranici sul consumo di alcol, né i militanti di un partito politico sono sempre tutti concordi con la linea ufficiale dettata dalla dirigenza.
A maggior ragione, è storicamente e concettualmente errato classificare una civiltà solo in chiave religiosa. Così facendo, si perdono di vista tutte le complesse interrelazioni culturali che la compongono e che attraversano le barriere delle appartenenze etniche, linguistiche e religiose. È un errore marchiano, ad esempio, affibbiare l’etichetta di “civiltà induista” all’India, dove i musulmani sono 145 milioni (il 14% della popolazione). Facendo un passo indietro nella storia, non si può dimenticare quanto la tradizione occidentale sia intrecciata con quella araba musulmana, che trasmise al Vecchio Mondo le conquiste della matematica indiana (sistema decimale e trigonometria) e preservò molti classici dell’antichità greca traducendoli in arabo e permettendo così le successive traduzioni in latino.
Infine, va sfatata la presunzione che i concetti di tolleranza, democrazia e laicità dello stato e le pratiche ad essi ispirate siano un patrimonio esclusivo dell’Occidente. Sen (che al tema ha dedicato un altro breve, ma incisivo scritto: La democrazia degli altri: perché la liberta non è un’invenzione dell’Occidente, Mondadori, 2004), fornisce qualche esempio. In Persia, la città di Susa fu retta per secoli da un consiglio elettivo; in Giappone, la “Costituzione di 17 articoli”, promulgata nel 604 dal principe buddista Shotoku, difendeva il principio del dibattito pubblico, che in Inghilterra si affermò solo nel 1215 con la Magna Charta; nel XVI secolo, mentre in Europa si diffondeva l’Inquisizione cattolica, in India il musulmano Gran Moghul Akbar sanciva la laicità del proprio impero, dichiarando: “Che nessuno si intrometta nelle faccende altrui in riferimento alla religione, e che a ciascuno sia consentito di accostarsi alla religione che gli aggrada”. / Amartya Sen. – Milano : Mondadori, 2004.
Ma assumere l’affiliazione religiosa quale criterio fondante non è solo un errore descrittivo, è un grave errore politico. Sen cita il caso dei ripetuti appelli del premier britannico Tony Blair ai “musulmani moderati”, allo scopo di favorire il dialogo con le altre fedi e contrastare la deriva fondamentalista. Un simile approccio, per quanto ispirato da buone intenzioni, produce in realtà effetti contrari. In primo luogo, perché porta ad attribuire maggiore importanza alle autorità religiose sminuendo quelle non religiose, il più delle volte col risultato di rafforzare l’establishment a scapito degli esponenti riformatori. In secondo luogo, perché in questo modo si spingono i cittadini a connotare il proprio senso di appartenenza in chiave religiosa, aumentando così la distanza tra comunità religiose differenti e svalutando altre possibili rappresentazioni della propria identità.
Ripensare il multiculturalismo
Lo sviluppo di questo ragionamento porta a riconsiderare il concetto di multiculturalismo.
“Esistono”, dice Amartya Sen, “due approcci fondamentalmente distinti al multiculturalismo, uno dei quali si concentra sulla promozione della diversità come un valore in sé; l’altro approccio si concentra sulla libertà di ragionamento e di decisione, e celebra la diversità culturale nella misura in cui essa è liberamente scelta (per quanto possibile) dalle persone coinvolte” (p. 151).
L’approccio del primo tipo, basato su una concezione “comunitarista”, è oggetto della critica di Sen, che obietta: “ciò significa che, in nome della diversità culturale, dovremmo sostenere il conservatorismo culturale e chiedere alla gente di rimanere attaccata al proprio retroterra culturale, senza cercare di prendere in considerazione l’idea di passare ad altri stili di vita, anche nel caso in cui si trovino buone ragioni per farlo? La negazione della scelta, implicita in questa linea d’azione, ci condurrebbe istantaneamente a contraddire la libertà, a cercare metodi e strumenti per impedire la scelta, che alcuni potrebbero voler fare, di vivere in modo diverso” (p. 117). E aggiunge: “Perorare la diversità culturale perché è quello che gruppi diversi di persone hanno ereditato dai loro predecessori non è palesemente un’argomentazione basata sulla libertà culturale (anche se a volte viene presentata come se fosse una tesi pro-libertà)”.
Così facendo, rileva Sen, non si costruisce il multiculturalismo, cioè l’interrelazione pacifica di più culture, ma un monoculturalismo plurale, cioè una coesistenza di culture diverse, ma divise in compartimenti stagni. Coesistenza che, in breve tempo, smette di essere pacifica. La Gran Bretagna, che in passato è stata capace di fare spazio alle altre culture “in modo eccellente”, negli ultimi anni ha però imboccato un sentiero rischioso, stabilendo di finanziare le scuole confessionali. L’effetto, certo indesiderato, è di creare tanti ghetti culturali, tante parrocchie che, non comunicando l’una con l’altra, non sono incoraggiate a mettere in discussione i propri valori fondativi: “Aggiungere altre scuole confessionali (…) rischia di sminuire il ruolo della ragione (…) in quanto le nuove scuole religiose offrono ai loro allievi scarse opportunità di coltivare l’uso della scelta ragionata per decidere delle priorità della loro esistenza” (p. 119).
“Conoscere per deliberare”
La massima del liberale Luigi Einaudi, padre fondatore della democrazia italiana, sembra riecheggiare in molti passi del libro di Amartya Sen, che in altre sezioni sviluppa il proprio pensiero occupandosi anche di globalizzazione e democrazia globale. Sen, del resto, ha familiarità con la tradizione liberale e federalista nostrana, avendo tra l’altro sposato in seconde nozze Eva Colorni, figlia di Eugenio, co-autore con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene.
“Le prospettive di pace nel mondo contemporaneo”, è il suo auspicio, “possono nascere forse dal riconoscimento della natura plurale delle nostre affiliazioni, e nel ricorso alla discussione ragionata in quanto semplici abitanti di un vasto mondo, invece di fare di noi stessi tanti detenuti imprigionati in angusti contenitori. Ciò di cui abbiamo bisogno sopra ogni cosa è una comprensione lucida dell’importanza della libertà di cui possiamo disporre per determinare le nostre priorità”.
Fabrizio Pesoli